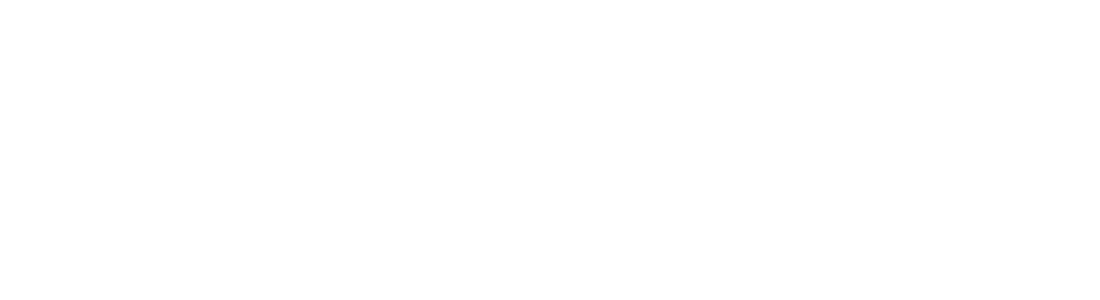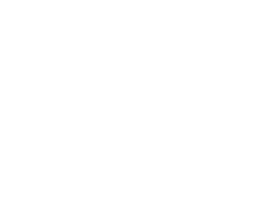UNA CITTA’
Da UNA CITTA’
N°107 Ottobre 2002
(pagg. 22-23)
Il 27% del suolo italiano è interessato da processi di erosione e per buona parte del sud, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria e Sardegna, già si parla di desertificazione. Cosa s’intende per desertificazione, esistono dei parametri generali per definirla?
La Convenzione delle Nazioni unite per la lotta alla desertificazione ha definito la desertificazione come degrado dei suoli dovuto a diversi fenomeni di tipo climatico e ambientale e, in particolare, all’intervento umano, intendendo come degrado dei suoli una perdita di quelle caratteristiche che permettono ai suoli stessi di trattenere il terreno, l’humus, l’acqua e quindi di mantenere la vegetazione. Dal vertice di Rio del ‘92 uscirono tre convenzioni per l’ambiente, una per il clima, una per la biodiversità e infine quella per la lotta alla desertificazione. Se le prime due si occupano di parametri e obiettivi di analisi del fenomeno a livello globale (gli accordi di Kyoto, ad esempio, tendono a definire la quantità di emissioni globali compatibili con un ristabilimento delle condizioni ottimali di effetto serra), la convenzione sulla desertificazione ricerca obiettivi e parametri a livello locale. Per intenderci, noi sappiamo che il cambiamento climatico ha determinato l’accelerarsi di fenomeni distruttivi ed erosivi su scala globale, ma non è vero che siano dovuti solo al cambiamento climatico globale, quello che in realtà interessa è il microclima locale. In genere la desertificazione è dovuta alla mancanza di pioggia, però anche la pioggia può essere distruttiva, e proprio il cambiamento climatico in corso sta producendo, insieme a una carenza di piogge in determinati periodi, eccessi di piogge in altri, perché il riscaldamento degli oceani ha prodotto una maggiore circolazione di acqua nell’atmosfera, maggiore energia, e quindi più precipitazioni, con estremi climatici violenti. E’ quello che vediamo sempre di più nell’area mediterranea, mancanza di acqua e poi alluvioni, siccità prolungate seguite da trombe d’aria. Dobbiamo aspettarci un sistema climatico che evolverà sempre di più in questa direzione. Comunque l’alternanza di situazioni positive e catastrofi fa parte della storia dell’umanità, che aveva saputo adeguarvisi nel corso del tempo, i sistemi tradizionali di organizzazione dei suoli erano basati sulla necessità di far fronte all’imprevedibilità e all’alternanza climatica. Adeguarsi significa quindi organizzare i terreni, il pendio per esempio inaridisce se non c’è pioggia, ma l’arrivo di una pioggia scrosciante può essere altrettanto distruttivo se i suoli non sono adeguatamente attrezzati con foreste o piantagioni di alberi, muri a secco, sistemi di raccolta e canalizzazione dell’acqua in grado di frenarne l’irruenza organizzandola in rivoli e di captarla in cisterne per le fasi di penuria. Tutte pratiche abbandonate per sostituirle con altre distruttive. E qui arriviamo all’azione dell’uomo: cementificare un’intera area per farne una città vuol dire impedire all’acqua piovana, che prima andava nelle falde e nel terreno, di essere assorbita dal suolo, disperdendola velocemente verso il mare. Abbiamo cementificato gli alvei dei fiumi e i litorali, abbandonato le montagne e il retroterra, tagliato i boschi, spostato le acque a grandissima distanza. Il vento assorbe l’acqua anche dalle foreste oltre che dal mare, sono veri e propri catalizzatori d’acqua per le precipitazioni. Fare i bacini idrici e portare l’acqua dolce nei posti dove manca può non permettere che si rinnovi dove è stata presa, perché se noi portiamo via l’acqua alteriamo il meccanismo climatico, basato su equilibri delicati di condensazione e precipitazioni, ed è possibile che dove una volta pioveva poi non piova più. Azioni del genere sono alla base della desertificazione. Desertificazione non vuol dire deserto, il deserto esiste in una fascia latitudinale in cui si è instaurato da ere geologiche, quindi ha creato una sua condizione di biodiversità legata agli adattamenti specifici in quell’ambiente, a processi di selezione instauratisi nel corso del tempo. Per desertificazione s’intende invece una situazione di degrado estremo e improvviso. E’ il tempo la variabile importante. La desertificazione non lascia agli organismi il tempo di abituarsi e di rispondere alle nuove condizioni, è la rottura traumatica di un equilibrio sperimentato e si instaura laddove, per condizioni latitudinali e climatiche, il deserto non dovrebbe esserci. Ma paradossalmente possiamo dire che anche il deserto può desertificarsi e questo avviene quando spariscono le oasi, i sistemi di raccolta di acque. Restringendo l’analisi all’Italia il fatto che il fenomeno sia presente in maniera massiccia al sud non esclude un interessamento anche delle aree settentrionali. L’anno scorso mi telefonavano dalla Valtellina o dalla pianura Padana non riuscendo a capire come mai non avevanoo più acqua e lamentando la siccità, in realtà, relativamente a quello che succede qui, da loro non è successo niente, ma la penuria idrica è un fatto relativo, dove si è abituati a grandi quantità d’acqua basta un abbassamento minimo che si grida all’allarme, del resto anche noi nel sud Italia consumiamo una quantità d’acqua enormemente superiore a quella che si usa nel Sahara. Comunque bisogna che ci abituiamo a riconvertire i nostri sistemi produttivi, industriali, ma soprattutto agrari, in sistemi a basso consumo di acqua, perché è questa la risorsa destinata a diventare sempre più rara e difficile da reperire, specialmente l’acqua potabile. Dobbiamo inoltre considerare che lo spreco di acqua che noi facciamo è comunque eccezionale, nel nord la maggior parte dell’acqua finisce nei fiumi e viene scaricata in mare senza essere raccolta.
Quali sono i maggiori settori di spreco?
Più ancora dell’industria l’agricoltura. La massima quantità dell’acqua attualmente utilizzata finisce in un’agricoltura assolutamente viziata dall’acqua. L’agricoltura di una volta utilizzava piccoli appezzamenti producendo un’amplissima varietà territoriale, non solo relativa alla diversificazione dello colture, ma anche alla presenza di zone non coltivate con caratteristiche diverse e necessarie al mantenimento di un equilibrio biologico, alla costituzione di un habitat, alludo ai cespugli di recinzione, i rigagnoli, gli aspetti a bosco, i drenaggi. L’agricoltura industriale invece ha bisogno di vaste superfici sempre uguali percorribili con grandi macchine, quindi distrugge tutta quella varietà di paesaggio che costituiva la ricchezza dell’agricoltura tradizionale. Addirittura qui nel sud zone prima considerate marginali come quelle carsiche, ora vengono macinate per farne una distesa piana da sfruttare per la produzione agricola, produzione che, in condizioni del genere, può essere fatta solo utilizzando massicciamente fertilizzanti artificiali e pesticidi, quindi enormi quantità d’acqua, perché l’acqua è l’unico mezzo per far assorbire questi elementi alla terra. Così si determina uno spazio agrario completamente artificiale, quasi plastificato, privo di fertilizzanti veri, e si crea un circolo vizioso. Non essendoci più la varietà di piante, cespugli e zone residuali, gli insetti nocivi si concentrano sulle piante coltivate, quindi la necessità di fitofarmaci, concimi chimici e acqua per farli assorbire, aumenta progressivamente. Noi non avremmo bisogno di un’agricoltura perennemente irrigata, così pompata e drogata dai concimi artificiali, l’abbiamo come prodotto di un circuito vizioso destinato ad ampliarsi inevitabilmente. Per cominciare i suoli non saranno più in grado d’assorbire acqua. Quest’inverno insieme alla siccità si lamentava la gelata dei suoli, i suoli cioè sono diventati una crosta di plastica e anche se piove l’acqua non penetra e le falde non si alimentano. Quindi siccità anche in presenza di pioggia. Ma il gelo quest’inverno era dovuto al cielo sereno, siccome la situazione di riscaldamento climatico ha comportato una mancanza di nuvole, il calore non veniva trattenuto e sparava verso l’alto, perciò in basso si creava il gelo, che a sua volta incrementava l’aridità. I meccanismi dunque sono complessi. L’agricoltura è solo una componente all’interno di un processo più vasto. Certo sarebbe importantissimo cominciare da qui a invertire un meccanismo, che, fra l’altro, ci dà prodotti insapori e gonfiati dall’acqua. Un frutto contiene l’85% d’acqua, si può dire che noi esportiamo acqua vendendolo, però nel suo costo il valore di quell’acqua non c’è. E si tratta di acqua potabile, perché noi, in un contesto globale in cui un miliardo di persone soffre per la mancanza di questa risorsa, usiamo l’acqua potabile per bagnare le piante. Quindi il vero costo di quest’acqua viene pagato in altro modo, quando importiamo arance da Israele, ad esempio, l’acqua che c’è lì dentro viene pagata ai costi straordinari della desalinizzazione e dei conflitti, la guerra infatti è il frutto della disparità tra chi consuma 200 litri d’acqua procapite e chi ne ha a disposizione 10. E questi sono i dati che dobbiamo aspettarci per il futuro del pianeta, è già iniziata l’era delle guerre per l’acqua, l’imminente conflitto iracheno sarà l’ultimo per il petrolio. Pensiamo per esempio al Nilo. Oggi esistono i mezzi per poter fare dei grandi bacini a monte dei grandi fiumi, se l’Etiopia facesse la diga sul Nilo l’Egitto che farebbe? Sarebbe costretto ad attaccare l’Etipopia, perché dipende completamente dal Nilo, ma questa situazione si potrebbe verificare in quasi tutto il mondo se si va avanti con la politica delle dighe, perché i confini dei grandi fiumi non coincidono con quelli degli stati. Si rende allora necessario un codice mondiale dell’acqua che fissi un diritto minimo per ogni abitante. Nelson Mandela a Johannesburg ha lanciato l’appello per garantire 50 litri d’acqua gratuiti al giorno ad ogni abitante della terra. Però, se diciamo questo, vuol dire che siamo veramente arrivati al dunque e tra un po’ lo dovremo dire per l’aria, vuol dire che si è monetizzato tutto, anche una risorsa assolutamente vitale. E allora l’unica risposta plausibile è il cambiamento del modello di sviluppo che determina questa situazione.
Tornando indietro?
Anche qui siamo di fronte ad un paradosso. Noi ci aspettiamo che le culture tradizionali siano arretrate e retaggio di popoli che definiamo sottosviluppati o, nel tentativo di essere più politicamente corretti, marginali, intendendo con questo dire che il futuro è un’altra cosa. Bene, innanzitutto non sono affatto marginali perché i 3/4 dell’umanità sopravvivono ancora grazie alle conoscenze proprie delle economie tradizionali, quindi il dato è strutturale anche se non si inserisce nella direzione stabilita per il pianeta dal modello di sviluppo espansivo. Del resto se davvero ci fosse l’intenzione di includere tutti in questo modello basterebbero pochi calcoli per dimostrarne l’impraticabilità in un’ottica globale, se tutti ogni giorno consumassero i 300 o 400 litri d’acqua procapite che consumiamo in Occidente l’acqua potabile del pianeta non basterebbe. La verità è che intanto i 3/4 dell’umanità consumano dai 10, il limite minimo vitale del Madagascar, ai 50 litri d’acqua procapite al giorno. Lo stesso ragionamento vale per la carta, se in Cina volessero consumarne tanta quanta ne consuma l’Europa gli alberi finirebbero, e così con le auto, se i Cinesi ne avesseri tante quante ne abbiamo noi l’atmosfera verrebbe completamente distrutta. Quindi il modello della società affluente non è proponibile nell’attuale situazione demografica, perseguirlo vuol dire andare incontro all’apocalisse, a catastrofi naturali e a guerre provocate dall’accentuazione sempre maggiore di disparità enormi. L’altro modello, quello della società tradizionale, continua a mantenere i 3/4 della popolazione del pianeta, ma paradossalmente proprio da loro viene visto come qualcosa di passatista, mentre nei paesi sviluppati comincia a diventare un vanto, pensiamo ai paesaggi della Svizzera o alla produzione delle case di qualità in Inghilterra, che vantano l’utilizzo di tecniche antiche. In realtà quindi il modello tradizionale è progressivo, è un modello vanto per le economie del benessere. I paesi più poveri, quelli che hanno subito uno shock culturale, sono invece soverchiati dalla modernità e, a causa della distruzione dei valori avvenuta, col loro modello tradizionale non riescono ad accettare da essa quello che effettivamente deve essere preso, tralasciando quanto c’è di negativo.
Puoi farmi degli esempi di come si è realizzato questo shock culturale?
Anche qui nel nostro sud si vede benissimo, il caso dei Sassi di Matera è un esempio evidente. Negli anni ‘70 si sono completamente spopolati, non era più moderno abitare nei Sassi. Ma lo stesso è avvenuto per tanti centri storici italiani, gli abitanti avevano accettato un’idea di modernità che rendeva tutto questo obsoleto, non praticabile. Per cui a Matera succedeva che nelle strade passava il carretto che distribuiva catini di plastica in cambio delle pentole di rame e la gente accorreva. Intanto però gli oggetti in rame si vendevano in mercati più avanzati, ad esempio in Germania, ad un prezzo alto. E’ un problema di fissazione di valori, noi oggi possiamo abitare le case medievali perché le abbiamo modernizzate con modifiche che, senza snaturarne la struttura, rispondono ad esigenze abitative contemporanee. Qui è il punto, la tradizione deve saper accettare dalla modernità quel grado di modificazioni che non ne snaturino la logica, ad esempio qui nei Sassi di Matera io uso la terrazza per captare l’acqua piovana e una cisterna risalente alla preistoria per conservarla, ma per diffonderla nelle toilettes uso una moderna pompa. Il futuro è questo, conservare la logica della tradizione innovandola quel tanto che è necessario per permettere alla tradizione stessa di perpetuarsi.
Per questo però ci vogliono tempo e consapevolezza …
Qui arriviamo al nodo della questione, in effetti lo shock culturale avviene perché i popoli non sono preparati, non hanno la capacità di risposta, ma soprattutto sono stati depauperati culturalmente ed economicamente. Qui la povertà è un elemento determinante, il popolo reso povero dalla perdita della sua tradizione è inerme e accetta la modernità senza poter controbattere. Faccio un esempio, noi diamo sempre la colpa della deforestazione in Africa al fatto che la gente cucina con le cucine a legna ed essendo povera ricorre al taglio degli alberi distruggendo il territorio, nella tradizione però non si andava a tagliare l’albero verde, si prendevano le radici e i rami secchi, esisteva la consapevolezza di stare all’interno di un ciclo ambientale che bisognava mantenere. Ora invece il degrado culturale si constata anche dalla sparizione dei simboli tradizionali, il bosco sacro, il tabù, l’albero degli antenati che andava rispettato; quando sparisce tutto questo la mancanza di risorse culturali per poter reagire crea un’estrema disponobilità a farsi soverchiare da qualsiasi cosa arrivi dall’esterno. Quindi è vero che la tradizione è un fatto dinamico in continua evoluzione, capace d’incorporare selezionando quello che le serve, da una pianta importata nel XVI secolo, ad esempio, ha avuto origine la cultura del pomodoro tipica dell’Italia mediterranea, ma se io posso abitare in una grotta preistorica, nei Sassi di Matera, è perché ho acquisito una solidità culturale. Gli abitanti di Matera non ritornano nei Sassi se non hanno la forza culturale di poter rivendicare la preistoria e il trogloditismo come una parte della loro cultura e tradizione, in mancanza di questo c’è la vergogna, i Sassi vergogna nazionale degli anni passati.
A proposito di fissazione di valori, le culture cosiddette marginali, sviluppate in ambienti difficili, si fondano sul riconoscimento dell’estrema delicatezza e labilità dell’equilibrio vitale e quindi sul principio dell’alleanza e della cooperazione tra le diverse forme di vita, valori che noi rischiamo di perdere.
La loro è la logica della simbiosi. Io credo che il darwinismo in realtà non dia una spiegazione all’evoluzione sociale e culturale, troppo spesso lo si usa estrapolando la nozione di conflitto per giustificare la prevaricazione, la selezione premia il più forte quindi implicitamente gli riconosce il diritto di soverchiare gli altri. La realtà invece non si può chiudere in questo schema, l’umanità stessa ne è la prova, probabilmente l’uomo era una scimmia gracile e mal riuscita e proprio questo ha costituito la sua forza perché l’ha spinto ad associarsi in comunità che usavano l’intelligenza piuttosto della forza e l’alleanza con altri esseri, il cane e gli altri animali domestici. L’oasi è l’esempio straordinario di questa capacità di simbiosi, sono gli stessi organismi che attiri mettendo la palma per creare l’ombra e la condensazione dell’umidità, che, decadendo, producono fertilità e creano il suolo. La necessità di stare insieme è alla base di ogni ecosistema, inteso come ciclo continuo, circuito perfettamente integrato e autopoietico. E questo si verifica inevitabilmente in qualsiasi situazione limite del pianeta, perché dove l’ambiente è difficile e richiede un’alleanza per la sopravvivenza è chiaro che l’umanità si è adattata. Ecco, io credo che le conoscenze tradizionali fondamentali per la sopravvivenza sono ancora conservate in queste comunità, dalle oasi del Sahara ai piccoli centri storici o rurali, ai diversi paesaggi agrari del pianeta, si tratta di saperle utilizzare.
Saperle utilizzare significa anche saperle recepire da modi di trasmissione del sapere molto diversi dal nostro?
Noi, almeno a partire dall’illuminismo, abbiamo scelto la codificazione tecnica come modo di trasmissione delle nostre conoscenze, le culture tradizionali invece usano i simboli. Caricando di simboli gli atti della vita quotidiana funzionali alla sopravvivenza ne conservano la memoria e li rendono trasmissibili, li fanno cioè diventare cultura. Il simbolo inoltre aggiunge all’atto un valore estetico, lo rende piacevole. Ecco, il punto è questo, le conoscenze tradizionali non separano la tecnica dall’estetica e dal piacere, in esse non c’è differenza tra l’orto che produce e il giardino fatto per la contemplazione, una tecnica tradizionale è nel contempo efficace e bella. Riproporre oggi le nostre tecniche tradizionali significa anche ricomporre la frattura netta fra tempo del lavoro e tempo dello svago e della cultura che si è prodotta nelle nostre società. Il simbolico infine attribuisce ai gesti e alle conoscenze un’aura di sacralità che ne permette la conservazione. Prendiamo le tecniche idrogenetiche, quelle legate al ciclo dell’acqua e sviluppate in ambienti dove questa risorsa non è immediatamente disponibile. L’acqua è una straordinaria metafora della vita, richiama il ventre materno, è indispensabile per l’esistenza. L’acqua è la parola, dicono i Dogon, un popolo del Mali che vive sull’ansa del Niger, e in effetti è vero, il nostro fiato è vapore, quando parliamo troppo abbiamo bisogno di bere, quindi l’acqua è comunicazione oltre che necessità vitale. Ma l’acqua è anche l’esempio di un ciclo produttivo che continuamente si rinnova e attraversa tutto il vivente, siamo tutti attraversati dalla stessa acqua che ha sempre circolato nella terra, quindi noi stessi siamo inseriti nell’ordine della ciclicità ed è questo il criterio che deve guidare le attività umane. Non possiamo spezzare il processo di circolarità senza aspettarci conseguenze e la circolarità si fonda sul perenne rinnovamento, non sulla distruzione e la produzione di scarti che non siano integrabili nel ciclo. L’acqua quindi è metafora dell’eterno ritorno, del fatto cioè che in un ecosistema il decadimento di alcuni esseri permette la vita di altri. Il frutto deve macerare sul terreno perché ci siano nuovi germogli, la materia vile, il letame, diventa humus, ed è da humus che deriva la parola uomo. I latini dicevano il campus laetus campo felice, ma era quello col letame. Il ciclo degli escrementi è importante per la nascita della vita. Nella città di Shibab si usano gli escrementi per rendere fertile il deserto e nelle oasi sarebbe un offronto se un ospite non offrisse i propri escrementi al campo, perché quello è il suo apporto di fertilità al sistema.
Tornando all’emergenza acqua, quali possibilità potrebbero offrirci le tecniche tradizionali?
Innanzitutto bisognerebbe ripristinare l’organizzazione tradizionale del paesaggio agrario, quindi nel sud i terrazzamenti dei pendii coi muri di pietra a secco, che sono fondamentali per evitare l’erosione e per captare l’acqua in eccesso impedendo che scenda impetuosamente a valle e conservandola per i periodi di penuria. Le pietre captano l’umidità notturna e la trasferiscono al terreno, qualsiasi ammasso di pietre produce acqua. Gli Egizi dicevano che c’è un altro Nilo nei cieli e da loro non c’erano nemmeno precipitazioni, quindi questo Nilo era la rugiada, la condensazione, lo stesso grande fiume nei cieli veniva utilizzato in tutte le Puglie quando non esisteva l’acquedotto pugliese, era un grande acquedotto celeste che veniva captato attraverso le specchie (così si chiamavano questi ammassi di pietra), i muri a secco, i trulli e i sistemi di captazione d’acqua sui tetti delle masserie.Bisognerebbe tornare a queste pratiche eliminando il modello di agricoltura estensiva meccanizzata e ripristinare sistemi di bosco e aree marginali, ad esempio le paludi. La rinaturalizzazione delle coste e la ricostituzione di situazioni osmotiche è indispensabile considerando che presto si porrà il problema di un rilevante innalzamento del livello dei mari e di aumento della salinità delle fasce costiere per l’intrusione di acqua marina. Ma ci sono anche esempi di tecnologia avanzata che sono nella logica della tradizione, per esempio il solare, una tecnica utilizzata da sempre, addirittura dipingendo di nero i tetti delle case per poter captare il calore, e che può essere associato con successo a tecnche che da sole non sarebbero proponibili. Penso ad esempio al sistema dei terrazzamenti, che, in genere, incontra due tipi di opposizione. Da un lato si dice che ci vuole troppo lavoro per farli e dall’altro si sottolinea la fatica di mantenerli dovendo salire a piedi o a dorso d’asino come si faceva una volta. Beh, intanto sistemi ad alta intensità di lavoro come quelli tradizionali sarebbero una valida alternativa alla disoccupazione, e poi l’ascesa dei pendii si risolverebbe utilizzando mezzi come quello sperimentato con successo a Ischia, una specie di monorotaia con motori elettrici ad energia solare che non ha nessun impatto sul paesaggio e permette di mantenere terrazzamenti che arrivano fino a mille metri d’altezza. Questa è una dimostrazione di come la tecnologia tradizionale possa continuare ad esistere grazie all’associazione con pratiche moderne. Dico di più, a mio parere il modo con cui l’umanità sta andando nello spazio è nella logica della tecnica tradizionale, una stazione spaziale ricicla tutti i suoi rifiuti e si alimenta con energia solare. Probabilmente nella luna si abiterà nelle grotte, in cunicoli sotterranei, si creeranno degli ecosistemi capaci di rigenerare l’atmosfera. Io sono convinto che la forza della tradizione rappresenti il futuro, ma un futuro che dovrà sempre misurarsi con la sostenibilità, cioè con trasformazioni capaci di produrre più risorse di quante ne consumano, questa è la logica da applicare a qualsiasi produzione e consumo.
Puoi farmi qualche esempio di riproposizione delle tecniche tradizionali di conservazione dell’acqua che abbia avuto successo?
Qui a Palagianello, una delle gravine dell’area ionica, abbiamo sperimentato con successo il rifacimento dei pendii terrazzati. C’era un pendio che si stava erodendo e franava, un masso minacciava la realizzazione di un acquedotto sottostante, perciò erano stati stanziati dei fondi per un intervento straordinario. Inizialmente si pensava a iniezioni di cemento, tiranti e un grande muro di contenimento che avrebbe stravolto la bellezza di questo canyon. Noi invece abbiamo proposto di rifare dei campi terrazzati e dei giardini murati, quindi una tecnica tradizionale che, mentre consolida il pendio, dà alle popolazioni dei giardini per passeggiare e in più produce acqua, perché abbiamo anche rifatto il sistema di cisterne. Modelli come questo sono sempre più proponibili, basti pensare a quanto si sta diffondendo la richiesta di prodotti biologici. E’ che non bisogna limitarsi a un discorso ideologico. Il modello agricolo occidentale non ha sbocchi, produce su scala sempre più vasta provocando distruzioni di risorse non più sostenibili e impedendo a tutti gli altri paesi di produrre coi sistemi agricoli tradizionali. Un uovo prodotto in batteria comporta lo spreco di mille litri d’acqua (per la pulitura delle macchine e altro), acqua che ovviamente non è calcolata nel prezzo dell’uovo. In questo modo produciamo migliaia di uova e le immettiamo nel mercato globale a prezzi talmente competitivi da scoraggiare le produzioni locali tradizionali. Siamo al paradosso di produrre cibi sempre più a basso costo e qualitativamente poveri o addirittura dannosi (pensiamo alla Bse) pagando costi ambientali altissimi, e contemporaneamente distruggere l’economia di aree sempre più vaste riducendole alla dipendenza alimentare.
Le tecniche tradizionali sarebbero conciliabili anche con gli attuali sistemi di urbanizzazione?
Per cominciare bisognerebbe rivedere i modelli di urbanizzazione, nelle città non dovremmo più avere superfici continue cementificate, andrebbero inserite delle fasce verdi per il ripascimento delle falde per consentire all’acqua piovana di infiltrarsi nel sottosuolo. Ma anche nelle abitazioni moderne potremmo fare delle terrazze per la captazione dell’acqua, che verrebbe distribuita negli appartamenti garantendo ad esempio l’autosufficienza per l’acqua potabile. Le acque di scarico si potrebbero riciclare nelle toilettes o negli orti. Potremmo addirittura pensare a dei giardini pensili, dei formidabili regolatori della temperatura, l’abbasserebbero d’estate ed eviterebbero dispersioni di calore durante l’inverno. Ogni estate infatti aumentano i consumi di condizionatori e tra poco salteranno tutti insieme come è già successo in California. In Giappone già esiste una legge che impone a tutti i nuovi grattacieli di avere un giardino sul terrazzo e i sistemi di raccolta di acque sono sempre più inseriti nelle architetture moderne. Nelle città il sistema dei giardini pensili si rivela utile anche per la penuria di verde. E non è vero che non sarebbero possibili al nord, in inverno si basterebbe utilizzare delle tecniche tradizionali di protezione come quelle usate sulla costiera amalfitana, stuoie di canne sostenute da pertiche di legno e distese sopra gli agrumeti. Probabilmente i centri storici hanno già al loro interno dei sistemi tradizionali che andrebbero recuperati, penso ad esempio a tutti i sistemi di canalizzazione, alle strade-fiumi che c’erano in tante città del nord. Tutte le grandi cattedrali del nord sono state costruite portando le pietre su dei rii che arrivavano un tempo fino alla piazza centrale e adesso sono coperti, si potrebbero riaprire e riportare alla navigabilità. Una città come Milano ha il problema enorme del rimontare delle acqua piuttosto che della diminuzione delle falde, hanno tutte le cantine piene d’acqua, perché prima esisteva un’integrazione tra il sistema dei fontanili, per la captazione delle acque, e quello dei navigli funzionale allo smaltimento. Poi tutti questi sistemi sono stati occultati e se nel periodo della grande presenza industriale la situazione ha retto perché l’acqua delle falde veniva assorbita dalla produzione, adesso che la grande industria è stata smantellata tutti i palazzi della città sono in pericolo per eccesso di acqua. Ma il rifacimento dei drenaggi di scorrimento è diventato indispensabile per moltissime città, andrebbero riaperte delle vie d’acqua, una bellezza anche per il paesaggio.
Di quali strumenti dispone la Convenzione per opporsi al poter delle multinazionali orientate invece verso il modello economico attuale?
Il potere di quella che io chiamo la vecchia economia è enorme e non vuole recedere. Di fronte a questo penso che l’approccio ideologico non serva, serve semmai dimostrare i vantaggi di un modo di produzione alternativo e la sua effettiva praticabilità, anche se resto convinto che il cambiamento non avverrà se non sull’onda della catastrofe, perché la storia dell’umanità lo dimostra, non è mai stata l’invenzione a determinare il cambiamento di modello, sono state le catastrofi ambientali a imporre un cambiamento sulla base di invenzioni che già c’erano e di scelte che si sarebbero potute fare anche prima. La civiltà della pietra non è finita perché mancavano le pietre. Tornando ai poteri della Convenzione sono quelli delle Nazioni Unite, poco determinanti. A Johannesburg abbiamo visto che la lobbie delle multinazionali era più rappresentata degli stati. L’appello di Mandela per i 50 litri d’acqua procapite sottolinea la drammaticità della situazione. Ebbene, la risposta delle multinazionali qual’è stata? Facciamo le centrali atomiche in riva al mare e usiamole per dissalare l’acqua e garantirla a tutti. Una risposta ipertecnologica, fondata tra l’altro su una tecnologia largamente pericolosa e nociva, che darebbe un potere enorme a chi possiede i capitali per realizzarla e controllarla. Io ho partecipato a tutte e cinque le conferenze mondiali fatte dalla Convenzione per la desertificazione, la mia impressione è che i paesi occidentali vi partecipino con l’intenzione di rallentare qualsiasi decisione si debba prendere, partecipano per salvaguardarsi rispetto alle opinioni pubbliche nazionali, ma non c’è la voglia di prendere delle decisioni drastiche. Anche i paesi europei non si discostano troppo dagli Stati Uniti in materia di sviluppo sostenibile, con la differenza che in Europa gli schieramenti sono tendenzialmente trasversali, non esiste una differenza tra governi di destra e di sinistra come in America. Là però ci sono stati come la California, che da sola vale dieci paesi industrializzati e va invece con decisione nella direzione dello sviluppo sostenibile, ad esempio proponendo entro i prossimi anni la totale abolizione delle macchine a benzina, che non è un’utopia, perché ormai è abbastanza chiaro che il futuro dell’auto sarà l’idrogeno. I paesi non industrializzati invece ritengono che questa sia la loro Convenzione, quella per l’Africa, anche se poi troppo spesso le classi dirigenti che li rappresentano contrattano piccoli aiuti in cambio di un atteggiamento più morbido. Comunque sono largamente presenti anche le Ong e quelle di questi paesi in particolare hanno una grandissima esperienza. Anche da loro comunque si riproducono le dinamiche presenti nei nostri paesi. Prendiamo la Cina, mentre si stanno facendo esperienze straordinarie di reintroduzione delle tecniche agricole tradizionali, ad esempio la risistemazione su larghissima scala delle dune con sistemi d’intreccio di foglie di palma seccate che ristabilizzano i terreni, nello stesso tempo si costruisce la grande diga sul Fiume azzurro, che comporterà una catastrofe immane. Insomma, la contraddizione è all’interno di tutti i paesi, e io penso che dai paesi non industrializzati dovrà venire la risposta più forte perché è una questione che sentono più immediatamente sulla loro pelle e quindi è più facile che il nuovo modello venga da lì, se però contemporaneamente cominciassimo noi a dare l’esempio della necessità di cambiare sarebbe un contributo enorme alle lotte di chi in quei paesi si oppone allo stravolgimento delle risorse. Del resto come possiamo dire ai Cinesi che loro non possono utilizzare la stessa quantità di carta che utilizziamo noi perché così facendo sparirebbero tutte le foreste del pianeta?
Comunque la vera sfida non è tanto quella posta dalla bonifica ambientale, quanto la progettazione di nuovi sistemi produttivi che siano già di per se stessi non inquinanti, processi produttivi cioè i cui scarti inneschino altri processi, come avviene nella natura. Si possono già fare alcuni esempi, ad esempio il riciclaggio della carta per la fertilizzazione dei boschi oppure l’esempio delle fogne di Calcutta, che invece di continuare a essere disperse nell’ambiente inquinandolo in maniera sempre più insostenibile, sono state filtrate e utilizzate per la fertilizzazione delle vicine risaie, bisogna insomma adottare logiche di questo tipo, fare dei problemi una risorsa.
Come dobbiamo interpretare la notizia data ultimamente con toni trionfali della riavanzata della vegetazione in alcune aree desertiche?
E’ una notizia sbagliata. Il dato vero è che si è ridotto il buco nell’ozono, e questo a dimostrazione che i provvedimenti presi su scala globale servono, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è servita. Invece il dato sul deserto è stato male interpretato. E’ un dato che ci aspettavamo, il deserto ha sempre avuto questi momenti, un’intera area può fiorire perché in condizioni particolari si creano delle precipitazioni. E’ quello che è successo ora: a causa del riscaldamento climatico in alcune zone del Sahara e nei deserti americani ci sono state delle piogge violente, ma hanno portato danni terribili, interi villaggi costruiti in terra cruda sono stati distrutti, quindi non si tratta di un arretramento del deserto, semmai di quel degrado di cui parlavo, acqua dove non avrebbe dovuto esserci in quelle proporzioni o comunque fenomeni che se prima erano sporadici, avvenivano, che so, ogni dieci anni, adesso si presentano con maggiore frequenza trovando le popolazioni impreparate. Un ecosistema può modificarsi solo coi tempi biologici, che permettono un’evoluzione adeguata delle forme di vita che lo compongono, cambiamenti drastici sono il sintomo del degrado. Avviene anche nella storia delle società umane, la trasformazione repentina crea shock culturale, invece l’assorbimento delle innovazioni nel tempo, che permette un adeguamento dei sistemi sociali e che viene filtrato dalla memoria e dall’esperienza, è auspicabile e sinonimo di progresso.